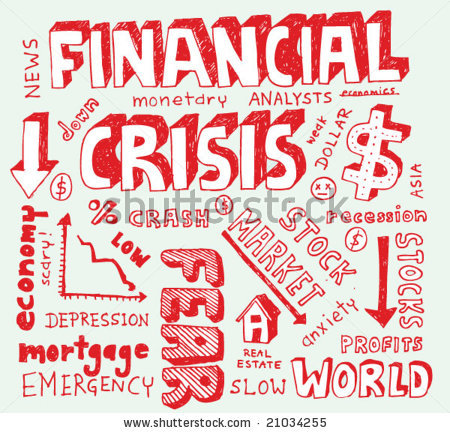Il problema dell’uscita dell’Italia dalla crisi
16 Maggio 2014Gianfranco Sabattini
Nel saggio recente “Recessione Italia. Come usciamo dalla crisi più lunga della storia”, Federico Fubini, editorialista de “la Repubblica”, osserva ciò che da tempo è nella consapevolezza dei più; ovvero, che l’Italia, dacché è scoppiata la crisi dei prestiti immobiliari americani subprime, è inserita in un processo di declino, che procede secondo ritmi così rapidi da rendere impossibile, non solo prevedere il punto di arrivo, ma anche rendersi conto di cosa sia successo. Per farsi un’idea della dimensione di ciò che sta accadendo, secondo Fubini, occorre qualche confronto con avvenimenti storici similari occorsi nel paese.
Non è possibile riscontrare una fase della storia economica del paese in cui si sia verificata in tempo di pace una contrazione del PIL del 9% in termini reali, fatta eccezione di quanto si è verificato tra il 1917 e il 1921, allorché l’industria pesante, cessata la guerra, è entrata in crisi, trascinando con sé il sistema bancario. La crisi attuale, però, non è spiegabile in funzione di un singolo trauma o della successione di un insieme di traumi, ma in funzione, secondo un’espressione di due studiosi americani (Daron Acemoglu e James Robinson, autori di “Perché la nazioni falliscono”), di particolari “punti di giuntura”, che possono essere raggiunti da ogni paese durante il suo sviluppo; punti, questi ultimi, che segnano momenti critici della sua evoluzione, connotando il suo futuro per una o più generazioni a venire.
L’Italia, secondo Fubini, si trova nel bel mezzo di uno si questi punti critici. Alcuni paesi a noi vicini, come ad esempio il Regno Unito di Margaret Thacher, hanno già dovuto affrontare la dura realtà del raggiungimento di un punto di giuntura ed hanno anche sperimentato il rigore delle politiche con cui tale punto è stato superato, al prezzo del diffondersi di pesanti disuguaglianze sociali. Sarebbe per molti italiani, osserva Fubini, una “cura” tutt’altro che piacevole; essa tuttavia non rappresenta l’unico modo per uscire dalla stagnazione che caratterizza la fase attuale dell’economia italiana, nel senso che il superamento della crsi può essere affrontato senza trascurare il problema delle disuguaglianze sociali.
Secondo Fubini, l’attuale fase della nostra economia si caratterizza per il fatto che la struttura sociale abbia conservato una stabilità che l’ha preservata da conati di disordini e di violenze; a giustificazione di questa sua affermazione, egli suggerisce una spiegazione che sinora è stata avanzata assai raramente in termini espliciti: i disordini e le violenze sociali sono stati evitati, perché in Italia il “risparmio dei padri” ha contribuito a “tenere a galla” l’intero sistema in declino. Ciò è accaduto perché il paese ha una popolazione che nel mondo è tra le più anziane, seconda solo a quella del Giappone che ha la popolazione più anziana in assoluto.
In Italia, come in Giappone, le classi di età avanzata costituiscono un “blocco elettorale”, cui il “torpore dell’economia non dispiace”. Nel nostro paese, quindi, esiste una tensione tra due campi di forze e quella tra queste che vorrebbe un’economia più dinamica e politiche pubbliche più orientate alla crescita non “è maggioranza nelle urne”, in quanto i più anziani costituiscono un “blocco” determinante sul piano elettorale. Ora, però, il Giappone, dopo vent’anni di stagnazione, mostra d’essere riuscito ad uscire dal tunnel della crisi, mentre l’Italia è ancora immobilizzata nelle sue spire. Come mai?
Fubini risponde all’interrogativo affidandosi all’analisi di uno storico dell’economia nell’Università di Oxford, l’italiano Andrea Boltho; questi, sulla scorta dell’esperienza dei tre paesi dell’Asse, Italia, Germania e Giappone, ha individuato alcune differenze nella loro evoluzione postbellica, cogliendone la principale nel fatto che il rallentamento del tasso di crescita verificatosi in Italia, a differenza di quanto è accaduto negli altri due paesi, non è un fenomeno recente; si tratta invece di una “tendenza che viene da lontano” e che ha tutta l’aria di potersi presentare sempre nei “paesi che non affrontano le radici del loro declino”.
Secondo Boltho, la tendenza al declino discende direttamente dalle modalità con cui è stata realizzata la ricostruzione nel dopoguerra. A differenza di quanto è accaduto in Giappone ed in Germania, in Italia, a causa della sua particolare debolezza nello schieramento tra i blocchi durante la guerra fredda, che faceva del nostro paese il “ventre molle” dell’alleanza occidentale, la potenza egemone dell’Occidente, cioè l’America, non ha fatto pressione perché fossero cambiate e modernizzate le istituzioni economiche; è per questo che le economie dei tre paesi dell’Asse, dotati di strutture economiche molto simili all’indomani delle fine della guerra, hanno avuto sviluppi assai diversi.
Le mancate riforme hanno creato i presupposti per le proteste operaie degli anni Sessanta, costituito le basi per il sistematico finanziamento monetario del deficit pubblico degli anni Settanta e causato il suo continuo aumento degli anni Ottanta, dal quale l’Italia non è più riuscita a liberarsi, perché si è progressivamente trasformato in “macigno” che ora ostacola e frustra qualsiasi progetto volto a rilanciare la crescita e l’occupazione. L’Italia, perciò, si è discostata notevolmente dall’evoluzione degli altri due paesi usciti sconfitti dalla seconda guerra mondiale; secondo Fubini, le mancate riforme economiche hanno determinato una continuità della contiguità fra capitalismo e politica, propria del corporativismo fascista, se non proprio sul piano dei valori, su quello delle istituzioni economiche; l’effetto più vistoso della sopravvivenza della contiguità è stato “il contributo alla generazione continua di disuguaglianze e iniquità nel paese”, che hanno eroso la credibilità degli obiettivi perseguiti da tutte le parti sociali coinvolte.
Ciò ha concorso a creare un sistema-paese fragile perché tutte le parti sociali (forze politiche incluse) non hanno avuto interesse a mettere in discussione i tratti strutturali che il sistema produttivo ha progressivamente assunto; partiti, sindacati e imprenditori hanno sempre preferito individuare le cause delle difficoltà del paese in capri espiatori esterni, denunciando così d’essere vittime di una crisi culturale profonda, che ha impedito loro di prendere coscienza delle cause reali dell’inserimento dell’Italia in una prospettiva di declino; rimpiangendo spesso la vecchia moneta nazionale col proposito di tornarvi, molti sono ora pronti “a portate il paese e la società alla bancarotta piuttosto di abbandonare i propri piccoli o grandi privilegi”, preferendo conservare la propria visione dello stato dell’Italia ancorata a decenni lontani del secolo scorso.
Fubini conclude la sua analisi sull’evoluzione dell’economia nazionale, affermando che lo status quo del paese non è la fine della storia; ciò perché l’Italia può fruire del vantaggio di un ricambio generazionale. Troppo poco, però, accontentarsi di ciò che il “buon vento” di tale ricambio può garantire alle future generazioni; sperare di porre rimedio in tal modo agli esiti della crisi culturale che attanaglia tutte le parti sociali del paese significa vivere di speranze che non è detto possano essere esaudite. Gli errori commessi durante e dopo la ricostruzione economica del dopoguerra, magistralmente indicati e descritti da Marcello De Cecco, hanno prodotto nei decenni successivi la struttura produttiva che tiene ora “inchiodata al palo” l’economia nazionale; poiché, al di là dei vantaggi che ci si può attendere dai soli ricambi generazionali, il rilancio della crescita potrà aversi solo con la correzione degli errori commessi nel passato, si può solo prevedere che perché ciò avvenga, sia necessario un tempo non inferiore a quello sinora trascorso per giungere alla situazione attuale. Tale amara considerazione porta ad accettare come realistica l’affermazione di Fubini, che la crisi in atto e il suo superamento siano destinati a segnare, non solo il futuro della prossima generazione, ma anche quello di molte altre successive.