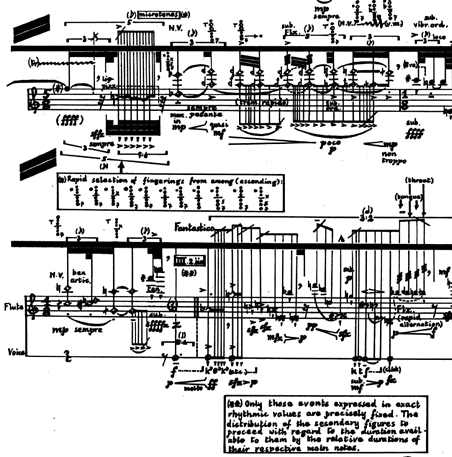L’importanza della musica contemporanea
1 Giugno 2017Antonio Trudu
Risale a poco meno di due secoli fa una lettera di Giacomo Leopardi a Giuseppe Montani in cui il poeta affermava che oltre a tutti i mali che affliggevano l’Italia, ”s’è levato un muro fra i letterati e il popolo, che sempre più s’alza, ed è cosa sconosciuta appresso le altre nazioni”. Era il 21 maggio 1819, l’anno in cui furono scritti L’infinito e Alla luna.
Ben presto Leopardi avrebbe parlato di “secol superbo e sciocco”, di “secol morto”, di “obbrobriosa etade”, di “abbiette genti” e più tardi si sarebbe reso conto dell’impossibilità di abbattere quel muro, dell’inevitabile vittoria dei moderati e dei liberali, che non a caso lo additavano come un pensatore “pericoloso” e, soprattutto, di scrivere per un pubblico possibile, per un lettore assente, prefigurando, come è stato osservato giustamente, le dolorose ribellioni delle future avanguardie europee.
Anche nel Novecento l’Italia si è distinta dal resto dell’Europa per aver elevato un muro sempre più alto e spesso, questa volta fra i musicisti e il pubblico. Mentre Eric Hobsbawm lo ha descritto come “secolo breve”, dal punto di vista musicale il XX è stato un secolo lunghissimo. Perché da un lato si può dire sia iniziato nel 1865, con prima rappresentazione del Tristano e Isotta, e dall’altro si può pensare che non si sia ancora concluso, visto che niente è successo, in campo musicale, negli ultimi lustri, da farci pensare che il XXI sia effettivamente iniziato.
E’ soltanto con la caduta del fascismo e con la fine della seconda guerra mondiale che la situazione italiana, in campo musicale, è diventata “unica”, rispetto agli altri paesi europei. In precedenza, sia prima sia dopo la nascita del fascismo, l’Italia non si differenziava troppo da Francia, Germania, Spagna, Svizzera. Certo, da noi la tradizione operistica ottocentesca, con la propaggine novecentesca costituita del verismo, aveva avuto il netto sopravvento su tutto il resto, ma le nuove tendenze della musica europea non erano ignorate e, soprattutto grazie alla “Generazione dell’80” (Casella, Malipiero, Pizzetti, Respighi) da più parti fu sentita l’esigenza di battere strade nuove. E sotto il fascismo la situazione non mutò. Si individuarono due correnti in lotta fra loro, i conservatori e i progressisti, ma c’era spazio sufficiente per tutti, se si pensa che in soli otto anni, tra il 1935 e il 1943, i teatri lirici italiani misero in scena più di 150 rappresentazioni di opere e balletti di autori viventi, non soltanto di autorevoli maestri come Mascagni (42), Giordano (33), Respighi (27) e Zandonai (21), ma anche di giovani come Pick-Mangiagalli (10), Rocca (8), Lualdi (7).
Quella che in qualche misura fu un’autentica guerra, fra i modernisti, capeggiati dall’autorevole Alfredo Casella, e antimodernisti, che erano la maggioranza, alla caduta del fascismo vide il trionfo degli antimodernisti, sia perché i pochi modernisti (Dallapiccola, Petrassi) si preoccuparono soprattutto di scrivere musica, sia perché alla caduta del fascismo non ci fu nessuna epurazione e i più agguerriti fra gli antimodernisti occuparono importanti posizioni di potere nei Conservatori, nei Teatri lirici e nelle Istituzioni concertistiche, nella Rai, nei quotidiani e nei settimanali.
Proprio dall’inizio degli anni Cinquanta fu messa in atto un’autentica campagna che aveva per obiettivo la delegittimazione e in qualche modo persino la cancellazione della musica “nuova” dalla vita culturale italiana. Pur con qualche lodevole e meritoria eccezione, gli innovatori e i progressisti furono isolati e sconfitti e grazie alla programmazione degli enti lirico-sinfonici e a un’autentica campagna di stampa volta a mettere in ridicolo le nuove tendenze musicali, i conservatori trionfarono.
Quanto alla stampa, accadde che persino nei giornali politicamente progressisti spesso i critici musicali fossero, invece, conservatori. Esemplare il caso del settimanale “L’Espresso”, il cui critico musicale era uno dei più convinti e direi accaniti avversari della musica nuova, Fedele D’Amico, che non perdeva occasione di gettare discredito sulle avanguardie e sulle tendenze musicali più avanzate. Nel 1992 ci fu addirittura un pamphlet di un intellettuale sulla cresta dell’onda, Alessandro Baricco, L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin, che da un lato esordiva citando il risultato di uno studio di un’Università americana secondo il quale la produzione di latte nelle mucche che ascoltano musica sinfonica aumenta del 7,5%, dall’altro dimenticava di citare una tendenza della musica contemporanea, il cosiddetto “minimalismo americano” (Reich, Riley, Glass, LaMonte Young), che contraddiceva la sua teoria secondo la quale la musica nuova è strutturalmente incomprensibile.
Come se qualcuno avesse potuto osare mettere in relazione il valore di Paul Klee, di Picasso, di Miró, di Mondrian con la produzione di latte delle mucche o scritto che l’astrattismo è strutturalmente incomprensibile. A questo proposito, non sarebbe inutile, credo, confrontare il diverso trattamento riservato dalla cultura italiana (scuola, musei e gallerie, stampa) alle arti plastiche e alla musica del Novecento.
Non è certo un caso che gli esponenti italiani della cosiddetta “avanguardia postweberniana” si rivolgessero con entusiasmo e speranza ai “Ferienkurse für Neue Musik” (Corsi estivi per la nuova musica) di Darmstadt, dove veniva offerta loro la possibilità di fare eseguire le proprie composizioni e di farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo. Non a caso Luigi Nono in una lettera al direttore di quei corsi all’inizio degli anni Cinquanta scrisse che lui e Maderna in Italia erano considerati “marziani”.
Sintetizzando al massimo, si può dire che il risultato sia stato da un lato quello di impedire, per quanto possibile, che il pubblico si accostasse alla musica nuova, dall’altro, grazie alla disinformazione o alla scorretta informazione, quello di far sì che il pubblico dei musicofili facesse di ogni erba un fascio, non rendendosi conto che all’interno della musica nuova c’erano diverse tendenze, anche molto diverse fra loro.
La responsabilità maggiore di questa situazione, accanto a quella dei Conservatori di musica, è stata quella delle Istituzioni lirico-sinfoniche, che anche oggi, salvo poche e comunque sporadiche eccezioni (Bologna, Palermo, Venezia, per esempio) dimenticano che uno dei loro compiti, una delle ragioni per cui Stato, Regioni e Comuni le sovvenzionano è “la diffusione del repertorio contemporaneo e la valorizzazione della musica d’oggi”.
Da questo punto di vista Cagliari, a parte le due miracolose eccezioni costituite dalle “Giornate di musica contemporanea” del 1977 e del 1978, non a caso legate al nome di Franco Oppo, è stata ed è, economicamente e culturalmente, la cenerentola delle istituzioni lirico-sinfoniche italiane e le poche volte che ha concesso qualche spazio alla musica del Novecento lo ha fatto in maniera del tutto coerente con la linea culturale dominante alla quale ho accennato, accrescendo nel pubblico la disinformazione e la confusione e contribuendo in maniera determinante al suo rifiuto del “nuovo”.
Non voglio chiudere, però, senza indicare quella che secondo me è la strada per cambiare questa disastrosa situazione. Dovremmo, innanzi tutto, prenderne atto, adoperandoci perché la tendenza si inverta. La scuola, dalle elementari all’Università, dovrebbe prevedere lo studio della storia della musica (imparare a suonare più o meno decentemente uno strumento è una cosa del tutto diversa) e lo studio dovrebbe partire proprio dal Novecento, per arrivare, procedendo a ritroso, alla musica antica. Poi, tutti noi dovremmo sensibilizzare i nostri referenti politici affinché prendano atto della situazione e si impegnino in questo senso, per esempio prevedendo che tra le competenze necessarie per diventare sovrintendenti e direttori artistici di un ente lirico-sinfonico ci sia anche la conoscenza non superficiale della musica contemporanea.
Infine, una considerazione che potrebbe suggerire qualche riflessione non del tutto inutile. Il rifiuto in blocco (o quasi) della musica contemporanea ha indotto e induce i responsabili di teatri lirici e istituzioni concertistiche a ignorare del tutto, autolesionisticamente, anche un genere musicale che incontrerebbe sicuramente i favori del pubblico e che potrebbe aumentare, e non di poco, le presenze e di conseguenza gli incassi: la musica per film.